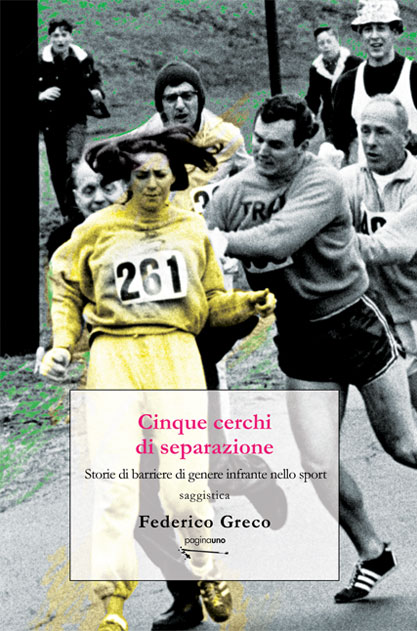La narrazione del calcio al tempo delle narrazioni – 3° puntata: Narrazioni legate alla storia dello sport
Da quando la televisione ha iniziato a dare sempre più spazio allo sport in diretta, le abitudini degli appassionati sono radicalmente cambiate. Ma non è di questo che vogliamo parlare, perché la narrazione legata all’evento in sé non è mutata altrettanto radicalmente: in fondo, i telecronisti hanno mutuato da giornalisti e radiocronisti la tendenza a usare l’enfasi, soprattutto quando di mezzo c’è l’azzurro. Giampiero Galeazzi che su Rai Due, nel momento in cui i fratelli Abbagnale tagliano il traguardo nel due con al Mondiale di canottaggio del 1990, grida
hanno vinto per la storia e con la storia
suggella in modo ineguagliabile questo passaggio di consegne.
Quello che, invece, più ci interessa in questa sede è che i network televisivi, sul finire del secolo scorso, hanno iniziato a guardare al passato, anche a quello recente, come a un bacino di storie da recuperare, rievocare e, in un certo senso, ri-raccontare. Un esempio in tal senso ce lo ha fornito la televisione pubblica con Sfide, sedici stagioni alle spalle tra dicembre 1998 e agosto 2016. Come sottolineano Matteo Anastasi e Paolo Carelli1, nel programma Rai «l’épos la fa da padrone» e il racconto «è inserito dentro la sua dimensione storica ma la storia culturale e sociale è utilizzata come contesto e puro frame identificativo di riferimento».
Nel recuperare e far rivivere il passato c’è poi stato chi, come Federico Buffa, ha saputo creare un proprio stile, una narrazione che fa dello «storytelling sportivo televisivo» la sua bandiera. Da sempre attento al contesto sociale, culturale, familiare, amicale in cui la storia raccontata si sviluppa o, meglio, da sempre attento ai riflessi che il contesto ha sulla personalità e sull’emotività del protagonista della storia raccontata, Federico Buffa con il passare del tempo ha sviluppato sempre più la sua vocazione da public historian, per riprendere un termine usato da Anastasi e Carelli.
Tanto che ha iniziato a proporre dei veri e propri one-man show in cui «c’è un intreccio costante e continuo tra la storia sportiva» degli atleti protagonisti e «la storia politica, culturale e sociale» ma in modo asimmetrico, visto che gli eventi sportivi sono «utilizzati come pretesto per ricostruire un periodo storico». Chiaramente la scelta di rendere tutto il più teatrale possibile determina anche in Buffa, come in Sfide, «una maggiore importanza data all’oralità “epica” che al documento».
È come se il portato emotivo che ha una storia legata al mondo sportivo sia, comunque, più rilevante del legame che quella stessa storia ha con il contesto sociale, culturale, economico di riferimento.
Il confronto con i modelli è fondamentale per capire come e dove potersi ritagliare uno spazio che meglio si addica alle proprie inclinazioni. Per dirla con quanto scrive Rudi Ghedini nell’introduzione al suo libro Rivincite,
Anche nello sport, il passato può apparire aleatorio e volatile, soprattutto quando mancano documenti, fotografie e filmati. I miti traggono alimenti dalla rarità dei testimoni diretti […]. Vicende solo immaginate non cessano di essere vere e assistiamo a processi di reinvenzione dei fatti, per adattarli a nuove esigenze politiche.
Di fronte a questa difficoltà, che gli storici conoscono bene e che narrazioni sportive inclini all’epicizzazione o a una mitizzazione decontestualizzata possono acuire, noi di Calcio Romantico, per esempio, abbiamo provato a sviluppare una forma narrativa che non lasci da parte il piacere del raccontare ma che, all’occorrenza, ricordi più il linguaggio asciutto e pieno di riferimenti bibliografici tipico dei saggi, che quello fiorito di una cronaca giornalistica.
Un «ibrido necessario» -come lo definirebbe proprio Ghedini-, funzionale alla nostra percezione dello sport come fenomeno sociale e culturale di notevole portata, legato a doppio filo al contesto in cui si muove. Anche perché fare dello sport un settore di ricerca, nel senso accademico del termine, è una scelta politica.
Non vogliamo, però, passare come blogger che conducono una crociata tout court contro chi tende a indugiare su toni epici quando parla di sport: non è facile raccontare una vittoria in un Mondiale di calcio o in un tappone alpino del Tour de France senza citare la parola impresa e, in fondo, un libro come Il corno di Orlando di Claudio Gregori, dedicato al ciclista Ottavio Bottecchia, mostra come linguaggio da poema cavalleresco e approfondita indagine giornalistica possano coesistere.
puntate precedenti: Ma che vuol dire narrazione?, Enfasi a mezzo stampa
puntata successiva: Nessun giorno senza calcio