La narrazione del calcio al tempo delle narrazioni – 2° puntata: La narrazione enfatica
Se non altro per una questione di anzianità, la stampa è il primo media a raccontare lo sport. A partire dalla fine del XIX secolo, grazie alla loro funzione informativa, i giornali contribuiscono a instillare nei lettori l’idea stessa della disciplina sportiva, intesa in senso moderno: non più attività fisica fine a se stessa, ma corpus di regole stabilite, con tanto di atleti o squadre protagoniste che si sfidano in competizioni ufficiali pubbliche e, quindi, fruibili al pari di spettacoli cinematografici o teatrali. Il tutto non senza conflitti di interesse, visto che molti dei grandi avvenimenti sportivi che ancora oggi si celebrano sono nati su iniziativa di quotidiani o di settimanali che avevano compreso quale ritorno in termini di immagine e di pubblicità potesse avere organizzare con successo una competizione ciclistica, un torneo di football o di lotta.
Giusto per avere un’idea, il primo Tour de France è organizzato nel 1903 dal giornale L’Auto di Henri Desgranges; la Gazzetta dello Sport raccoglie la sfida e nel 1909 appronta il primo Giro d’Italia; nel 1907 il già citato L’Auto e il suo concorrente Les Sports organizzano due distinti tornei di lotta, considerati entrambi antesignani dei Mondiali. Persino la Coppa dei Campioni d’Europa nascerà, anche se molto più tardi (1955), su idea di un giornalista, Gabriel Hanot, tra l’altro ex calciatore ed ex allenatore della Nazionale francese
Con l’aumentare del numero di chi è interessato alle vicende sportive in sé, con il formarsi delle singole federazioni e con la nascita di competizioni nazionali e internazionali, lapidari resoconti delle gare che ci son state o avvisi su dove e quando ci sarà il tal evento non bastano più. Per venire incontro a tali esigenze la carta stampata assume, in una duplice forma, il ruolo di elemento sostitutivo: il lettore non solo può informarsi delle competizioni sportive cui non ha potuto assistere, ma può anche rivivere, nella prosa degli inviati, le emozioni provate di persona.
Anche sulla stampa italiana i corrispondenti cominciano a servirsi di un linguaggio fatto di termini e di locuzioni sempre più specifiche e, al contempo, ben immersi nel clima nazionalista che si diffonde prima con la Grande Guerra e poi con il Ventennio, si lanciano in minuziose cronache dell’accaduto piene di enfasi.
Così, soprattutto quando di mezzo ci sono competizioni internazionali, il terreno di sfida viene descritto, più o meno tacitamente, come un campo di battaglia, in cui i campioni italiani sono equiparabili a soldati che lottano per difendere l’onore della loro patria. Giocoforza, i successi diventano epiche imprese, mentre le sconfitte sono spesso dovute alla sfortuna, alle condizioni atmosferiche, alla condotta violenta degli avversari e, a volte, vengono fatte passare come vittorie “morali”. Il 1934 ci offre un saggio di questo approccio: a giugno, Bruno Roghi, il teorico dell’enfasi sportiva come «forma canonica del linguaggio giornalistico per descrivere gli avvenimenti agonistici»1, saluta sulla Gazzetta dello Sport la vittoria italiana al Mondiale con un’editoriale dal titolo Soldati d’Italia; a novembre, è tutta la stampa italiana a esaltare la prestazione degli azzurri sconfitti 3-2 in trasferta dagli inglesi e a creare la leggenda dei Leoni di Highbury.
Ambasciatori dell’italianità, quando impegnati in eventi fuori dal territorio nazionale, ai campioni più noti si richiede di essere anche depositari dei più alti valori etici e morali nella vita di tutti i giorni. Una lettura che neanche l’avvento della Repubblica interrompe, tanto che, quando a metà degli anni Cinquanta compare sulla scena la “Dama Bianca” Giulia Occhini, la popolarità del campionissimo Fausto Coppi subisce una grossa battuta d’arresto e non per questioni legate al suo rendimento in bicicletta.
Un altro indizio di quanto poco cambino le cose nella narrazione dello sport, nonostante la caduta di Mussolini, ce lo dà la lunga carriera del già citato Bruno Roghi: vero e proprio aedo dei successi sportivi del fascismo, egli ricopre il ruolo di direttore della Gazzetta dello Sport dal 1936 fino a quando, all’indomani dell’otto settembre 1943, si dimette e viene messo al bando dalla Repubblica di Salò,2 cosa che gli consentirà di uscire “pulito” e di dirigere il Corriere dello Sport tra il 1947 e il 1960 e Tuttosport dal 1961 fino alla sua morte, avvenuta nel 1962. Ancor più lunga la traiettoria dell’immaginifico Nicolò Carosio, che per il commento radiofonico rappresenta ciò che Roghi è stato per la carta stampata: radiocronista sportivo per l’EIAR a partire dalla Coppa del Mondo del 1934, cantore delle gesta della Nazionale di Pozzo, continua a lavorare per la radio e la TV di stato fino al 1971, quando è forzatamente mandato in pensione a seguito di una mai ben chiarita “gaffe”.3
E se sotto il fascismo ha mostrato tutta la sua politicità la scelta di virare su un linguaggio ricco di metafore guerresche e di colorite iperboli per esaltare le imprese compiute dagli italiani, quello stesso racconto dai toni enfatici, usato in dosi massicce e ricondotto a sentimenti nazional-popolari, diviene paradossalmente nell’Italia repubblicana funzionale alla narrazione dello sport come avulso dalla politica, come terreno che unisce e non divide. Ecco, ad esempio, l’incipit del pezzo con cui l’organo ufficiale del più grande partito d’opposizione, L’Unità, annuncia nel pieno dell’anno simbolo della contestazione, il 1968, la vittoria ottenuta dagli azzurri a Roma nella finale dell’Europeo di calcio:
Sono le 23 di lunedì 10 giugno: da tempo la notte, una notte stellata, tiepida e densa di umori dopo la giornata di pioggia, è scesa sulla città deserta, ma qui, nel catino dell’Olimpico, sembra di essere in pieno giorno. Alle luci dei riflettori si aggiungono infatti le fiamme vivide e saltellanti delle fiaccole mentre i bengala rossi, verdi e azzurri si incrociano in una sarabanda di scoppi.
Senza peccare di superficialismo, possiamo dunque affermare che da oltre un secolo la carta stampata ci ha abituato a una narrazione sportiva piena di enfasi, giustificandola a posteriori perché più adatta a restituire l’emozione del momento e servendosene a priori perché funzionale, ad esempio, a identificare gli atleti e le atlete con la Nazione, con il Popolo, ma solo in quanto ethos, e quindi astratti dal contesto in cui essi o esse operano.
puntata precedente: Ma che vuol dire narrazione?
puntata successiva: Anche lo sport ha una sua storia


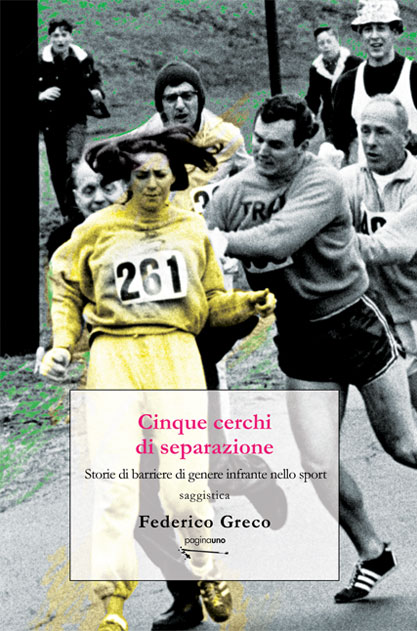

Trackback/Pingback