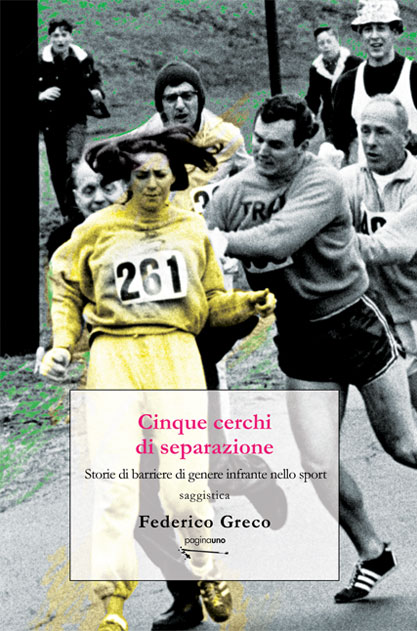La narrazione del calcio al tempo delle narrazioni – 1° puntata: Una definizione
In due mesi di lockdown per Coronavirus, tra marzo e maggio del 2020, non si sono giocate partite di calcio, basket e pallavolo, non si sono disputati gran premi e giri ciclistici e tutte le principali manifestazioni sportive sono state annullate, spostate, riprogrammate, anche più volte. Eppure non si è mai smesso di parlare di sport, professionistico e non solo, visto che attività fisiche quali il jogging o la ginnastica in casa fai-da-te sono entrate dentro quel perverso meccanismo mediatico che andava alla ricerca, alternativamente, di persone responsabili della diffusione del virus o di comportamenti virtuosi in tempo di quarantena.
Del resto, tutto ciò che ha a che fare con il corpo ha da sempre delle implicazioni sociali, culturali, economiche e politiche (o biopolitiche, se preferite) ed è proprio questo aspetto dello sport che nel 2011 ci ha spinto ad aprire questo blog.
Quasi a sottolineare la causa prima del nostro moto, in calce al primo pezzo scritto nei mesi di lockdown osservavamo come la pausa per il Coronavirus stesse mostrando quanto
lo sport, pur senza il momento agonistico, andava avanti lo stesso, a far parlare di sé, a muovere opinioni, a produrre narrazioni.
Il termine “narrazione” è contenuto anche nel titolo del pezzo e dei successivi e, a dire il vero, è entrato così a far parte del nostro linguaggio che non ci siamo mai fermati un attimo a osservare una cosa fondamentale: che cosa sia una narrazione (o che cosa, secondo noi, vada inteso per narrazione) non lo abbiamo mai spiegato!
Proveremo a tappare questa falla e ne approfitteremo per mettere in luce come, dietro al racconto dello sport fatto dai media, siano ravvisabili narrazioni, alcune vecchie addirittura di cento anni. Partiamo, però, come promesso, dalla definizione.
In un articolo scritto nell’ottobre del 2013 per il portale dell’Istituto Treccani -sarà nostro fidato compagno di viaggio- la terminologa Licia Corbolante notava come da alcuni anni in inglese, in ambito giornalistico, fosse molto in voga la parola “narrative” per designare una particolare forma di comunicazione. Questo nuovo concetto, continuava la studiosa, era reso in italiano con due neologismi semantici, ovvero con due parole già presenti nel nostro lessico, a cui però si assegnava un nuovo significato: “narrativa” e “narrazione”. Superfluo dire quale dei due termini abbia preso il sopravvento, soprattutto nelle nostre teste. Ad ogni modo, a partire dall’edizione del 2017, il vocabolario Treccani rendeva lemma l’osservazione della Corbolante e spiegava che narrazione adesso poteva anche voler dire:
Forma di comunicazione argomentata tesa a conquistare consensi attraverso un’esposizione che valorizzi ed enfatizzi la qualità dei valori di cui si è portatori, delle azioni che si sono compiute e si ha in programma di compiere, degli obiettivi da raggiungere
La definizione, che ricorda molto quella riportata come terzo significato di “narrative” dall’Oxford Dictionary («a representation of a particular situation or process in such a way as to reflect or conform to an overarching set of aims or values»), suggerisce che chi fa una narrazione si preoccupa del contenuto, ma ancor più della forma, della modalità tramite cui comunica. O, forse, che per fare una narrazione i contenuti non sono sempre necessari, mentre fondamentali sono «valori», «azioni», «obiettivi».
Ma in che modo è possibile parlare di narrazione in ambito sportivo? In uno degli esempi riportati dal vocabolario Treccani nella fraseologia si parla di «narrazione della nuova amministrazione» di Torino in merito al taglio di alcuni contributi. Siamo, dunque, di fronte a un determinato fatto e a una serie di dichiarazioni rilasciate e/o di atteggiamenti tenuti dal consiglio comunale della città piemontese.
Possiamo allora convenire che, se l’episodio specifico che produce reazioni, commenti o prese di posizione è riconducibile al mondo dello sport, abbiamo una “narrazione sportiva”. In Tutte le bufale dei pro e dei contro le Olimpiadi 2024 a Roma, ad esempio, si parla di narrazioni positive e di narrazioni negative connesse alla presentazione ufficiale della candidatura di Roma per i Giochi estivi del 2024, insistendo sull’assenza di un fact-checking, ovvero di un controllo delle informazioni alla fonte, fatto da chi con queste narrazioni è venuto in contatto.
Se poi guardiamo come nel corso degli anni potrebbe mutare il racconto di una grande vittoria o di una ingiusta sconfitta, eventi già di per sé inclini a mitizzazioni ed epicizzazioni, ecco spiegata la preferenza da noi accordata al termine narrazione in tempi non sospetti, ovvero quando scrivemmo del match tra Perù e Austria, quarto di finale del torneo di calcio delle Olimpiadi del 1936.
Non è, però, solo il singolo episodio a essere adatto al nostro neologismo semantico. Nel 2015, infatti, non era difficile sentir parlare dei segreti della narrazione di Renzi. Lasciando da parte facili ironie, segue che è lecito parlare di narrazione anche se si è di fronte a un progetto politico, sociale, culturale sviluppato nel lungo periodo, purché in esso si ravvisi continuità nei modi e, soprattutto, nelle forme di comunicazione scelte.
E allora, dato che CIO e FIFA sono stati sin dalla loro nascita dei veri e propri agenti all’interno dello scacchiere internazionale, a volte avallando, a volte anticipando grandi mutamenti politici, economici o sociali, non è certo una forzatura parlare di narrazione decoubertiniana dell’ideale olimpico, per mettere in evidenza come questo fosse funzionale a uno sport praticato solo da una ristretta élite di persone che potevano permettersi di non trarne benefici economici; o di narrazione della FIFA di Havelange, per sottolineare come, sotto l’apertura verso Africa e Asia, non ci fosse da parte dei vertici del mondo del calcio la volontà di essere più “democratici”, bensì quella di espandere la propria influenza economica in continenti ancora quasi inesplorati.
Ci sono, infine, narrazioni che potremmo definire meta-sportive, perché si riferiscono allo sport inteso come totalità. Se vogliamo, la celeberrima frase mens sana in corpore sano altro non è che un modo per porre l’accento sui valori che lo sport ha, senza poi stare a controllare se gli uomini servono alti, belli e forti perché devono andare a difendere la patria facendo i soldati e le donne sane e robuste perché devono sfornare figli.
Un nesso salute del corpo-salute della mente che è stato, invece, ignorato o, meglio, condannato nel corso dei mesi di sospensione per Covid19, in cui l’attività fisica è stata spesso associata a disvalori (mancanza di rispetto per la comunità) e ad azioni irresponsabili (diffusione del virus), senza un’effettiva analisi su quale impatto avessero sul numero di contagi pratiche come il jogging mattutino.
Esattamente tutto quello che rende fiumi di parole dette o scritte una narrazione in base alla definizione su riportata.
puntata successiva: Enfasi a mezzo stampa