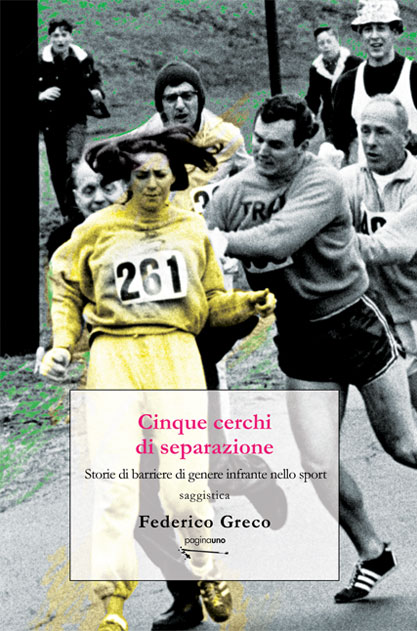La narrazione del calcio al tempo delle narrazioni – 4° puntata: Pay-tv e modalità di fruizione
La Rai dal settembre 1986 mostra con regolarità il sabato pomeriggio il secondo tempo di un match della A1 maschile di basket. A partire dal 1990, al sabato sportivo di Rai Due, si aggiunge la trasmissione di un incontro della A1 maschile di pallavolo, sfruttando l’onda lunga delle prime vittorie internazionali degli azzurri di Julio Velasco. Grazie al fatto che ne è stato chiesto l’anticipo al sabato per imminenti impegni europei, il 17 aprile 1993 tutti possono vedere su Rai Uno la partita di campionato tra Milan e Juventus. La rivale Fininvest, dal canto suo, ha l’esclusiva sulla Coppa Italia dalla stagione 1990/91 e trasmette un match per ogni turno, anticipandone la disputa al martedì o posticipandola al giovedì.
Insomma, i segnali che qualcosa sta cambiando nel mercato dello sport televisivo, calcio in primis, ci sono già tutti quando arriva l’ultimo weekend di agosto del 1993.
Monza-Padova sembra una partita come le altre nel panorama che offre la prima giornata della Serie B 1993/94. Anzi, a volerla dire tutta, il ritorno tra i cadetti della Fiorentina, dopo 63 anni passati nel massimo campionato, desta molta più curiosità. C’è, però, un particolare che non può passare inosservato: tutti i match vanno in scena il pomeriggio di domenica 29 agosto 1993, tranne quello tra brianzoli e patavini che si gioca sabato 28 alle 20:30 per esigenze televisive e non per particolari richieste di una delle due società.
Monza-Padova è, infatti, il primo match della storia del campionato italiano di calcio a veder variato il proprio orario di inizio per essere fruibile dagli abbonati di una pay-tv. La sera dopo è la volta di un incontro valido per la prima giornata di Serie A, Lazio-Foggia e -come da contratto con la Lega calcio- anche nei week end successivi la tv a pagamento propone un anticipo di B e un posticipo di A riservato ai soli possessori di apposito decoder.
È più di un anno che il network in questione, Tele+, trasmette in esclusiva per i suoi abbonati alcuni eventi sportivi, anche di un certo livello (vedi, ad esempio, il Motomondiale), ma, per far capire a tutti che qualcosa nella fruizione del calcio sta per cambiare per sempre, nulla vale come un Milan-Juventus che, a differenza di quello di qualche mese prima, solo chi ha pagato può vedere in tv1.
Per quanto di qualità possa essere l’offerta riservata a cinema, documentari o serie tv, per quanto grande possa essere lo spazio dedicato a ciò che è sport ma non è pallone, è sul bisogno indotto negli appassionati di poter vedere in tv tutte le partite della propria squadra del cuore, ovunque essa giochi, che provano a costruire le loro fortune le singole piattaforme a pagamento che in Italia, a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso, via via nascono, prosperano, si fondono, cambiano padrone e qualche volta anche muoiono2.
A poco più di un quarto di secolo di distanza, possiamo affermare che la completa finanziarizzazione dello sport ad alti livelli (e non solo) è stata agevolata dalla presenza su varie piattaforme di canali tv, a pagamento o in chiaro, a esso interamente dedicati, e dal miglioramento delle infrastrutture legate alla rete, ormai accessibile ovunque e in grado di supportare streaming video di alta qualità. Grazie all’aumento dell’esposizione mediatica, campioni e grandi club sono diventati veri e propri brand; tifosi e appassionati, percepiti ormai come meri clienti, “acquistano” le gesta dei loro beniamini assistendo dal vivo o in tv, comprando gadget che ne alimentano il merchandising e, persino, lavandosi i capelli con lo shampoo antiforfora da loro reclamizzato.3
Inoltre, siamo ormai abituati a leggere di società di calcio che considerano le entrate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi più importanti degli incassi ottenuti al botteghino e ci appare quasi ineluttabile che le partite delle coppe europee, di A e di B, ma anche quelle di Coppa Italia e delle serie minori, vengano spalmate su più giorni e giocate a volte in orari impossibili per chi lavora e vorrebbe andare allo stadio ad assistervi. In modo che nessun giorno sia senza calcio.
Ma lo “spezzatino” del football nostrano è solo il riflesso su piccola scala di una pratica che colpisce tutti i tornei e tutti gli sport di squadra che abbiano una reale o presunta spendibilità televisiva e anche -se non soprattutto- grandi manifestazioni come le Olimpiadi. Resta, infatti, emblematico quanto fatto in occasione di Pechino 2008 per Micheal Phelps e per la platea statunitense che attendeva con ansia i suoi otto ori: finali spostate nella mattinata cinese, così a New York o Los Angeles è sera; gare sovrapposte il meno possibile per non limitare le prestazioni dello Squalo di Baltimora; società che effettua il cronometraggio ufficiale sponsor personale del campione per vincere anche i 100 farfalla… ma questa è un’altra storia. E abbiamo volutamente chiamato in causa i cinque cerchi perché una prima, grande accelerazione a livello globale verso la visione dell’evento sportivo come prodotto da vendere e da cui ottenere ricavi la si è avuta in vist a dei Giochi Olimpici di Seul del 1988, con la stipula di un programma quadriennale di sponsorizzazioni tra il CIO e la International Sport Leisure Agency di Horst
Dassler.
Qui, però, il focus è sulle narrazioni. Ebbene, Tele+, Stream TV, Sky, DAZN, Eurosport e tutte le altre piattaforme che hanno operato o operano nel settore diritti tv o streaming hanno fatto mutare per sempre le modalità di fruizione, in particolare, del calcio, ma non hanno regalato narrazioni che andassero molto al di là dell’incensazione del proprio prodotto, perché troppo legate alla finanziarizzazione dell’industria del tempo libero.
Tuttavia, questo processo in atto da più di trenta anni, ha dato origine a tutta una serie di contro-narrazioni. Molte delle quali non certo definibili “virtuose” o coerenti.
puntate precedenti: Ma che vuol dire narrazione?, Enfasi a mezzo stampa, Anche lo sport ha una sua storia
puntata successiva: Calcio moderno, antimodernismo e nostalgia